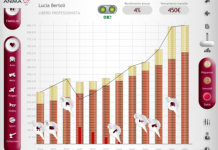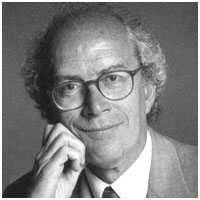
Una mentalità industriale ed il conseguente approccio gestionale può esser definita come una focalizzazione sulla propria industria e sui temi di efficienza e di mercato; ne consegue una focalizzazione sul conto economico e sul lungo termine, dato che nel breve termine non si può quasi mai fare molto. Una mentalità finanziaria può esser definita come una focalizzazione su valori e transazioni (se il valore è basso compro, se è alto vendo); inoltre ha sempre una connotazione opportunistica, indifferente a tradizioni e stabilità. Non c’è amore per il prodotto, gli impianti, la storia dell’azienda; c’è una forte attenzione ai flussi di cassa, allo stato patrimoniale, ai valori relativi e presumibilmente al breve termine.
Due visioni del valore
Gli imprenditori che hanno fondato l’azienda si vantano della propria mentalità industriale, mettono in evidenza la grande creazione di valore che è stata realizzata partendo da zero, e disprezzano quelli con mentalità finanziaria. I figli degli imprenditori scimmiottano sovente l’atteggiamento e i dogmi dei padri ma evitano di misurare di quanto è aumentato il valore dell’azienda da quando l’hanno ereditata e gestita. A tutti questi fanno eco giornalisti, associazioni, politici che decantano le virtù delle aziende familiari ed esaltano i meriti di quelle famiglie che da tempo immemorabile passano la proprietà di generazione in generazione, sempre operando nello stesso settore. Essere un industriale nel senso classico è anche molto comodo: nel tempo si sviluppa una dettagliata conoscenza di tutti gli aspetti rilevanti del business, il che evita la fatica di pensare. Anche i figli di un industriale sono capaci di parlare eloquentemente del business illudendosi che la conoscenza equivalga a competenza. Sovente però sono proprio i dogmi, l’eccesso di conoscenza e lo sviscerato amore del proprio business che non consentono di vedere i nuovi trend tecnologici, i nuovi modelli di business, i nuovi competitor che arrivano da settori laterali. Gli operatori di tipo finanziario non hanno un particolare senso di superiorità o inferiorità; se i risultati sono positivi si considerano bravi, se no non ci sono scusanti. Un’azienda, un impianto, un qualsiasi asset è semplicemente una merce di scambio; se alla fine di un certo periodo il saldo fra profitti e perdite è positivo, lo è anche il giudizio su quello che si è fatto. Qualcuno più attento include nella valutazione anche il livello di rischio che si è corso e la quantità di operazioni fatte: correre grandi rischi e guadagnare con poche operazioni è simile ad avere fortuna con una lotteria, mentre correre rischi medi e guadagnare in tante operazioni invece dimostra una vera abilità. Guadagnare, però, non significa fare profitti: nel periodo di riferimento significa remunerare il capitale di rischio attraverso capital gain e dividendi di più di quanto si sarebbe potuto fare investendo passivamente in un indice delle borse mondiali, più un quantum per tener conto del maggior rischio. In pratica, se non si riesce a dare un ritorno totale maggiore del 15% composto annuo non si è davvero guadagnato. La cosiddetta mentalità industriale non è limitata agli imprenditori; anche le aziende manageriali tendono ad essere focalizzate sul proprio settore, e talvolta sono ossessionate dai risultati di breve termine (la sindrome americana dei “quarterly earnings”). Molte di queste aziende entrano in un circolo vizioso: selezionano la propria classe dirigente dall’interno (quindi senza esperienze diverse dal proprio settore), fanno investimenti nei mercati e nelle produzioni che conoscono, provano a diversificare mettendo a capo dei progetti i manager meno bravi o meno “in carriera” (e quindi normalmente ottengono risultati negativi) e alla fine si convincono che il loro destino sia quello di esser sempre più monoculturali e specialistici del proprio “mestiere”; anche gli analisti di borsa contribuiscono a tale focalizzazione penalizzando le società diversificate o difficili da comprendere.
I nodi da sciogliere
Questo modo di pensare e di funzionare può essere valido in un contesto di espansione continua dove ci sono opportunità di sviluppo per tutti; mostra invece dei limiti pericolosi nel contesto attuale caratterizzato da stagnazione generalizzata, da molti settori in contrazione e dall’affermarsi delle bolle come una regola invece che un’eccezione. Quando il mercato è stagnante, un industriale non si rassegna a tale situazione ed è sempre in attesa della “fine della crisi”: continua ad investire e ritarda le decisioni spiacevoli come i licenziamenti o le chiusure di impianti. Un finanziario è più pronto a vendere aziende o impianti che domani varranno meno di oggi e a valutare con distacco se il breakup dell’azienda possa valere di più di una gestione unitaria. Ci sono settori che sono entrati in una inevitabile crisi secolare, sia per motivi strutturali (per esempio, le costruzioni crescono quando c’è da dotare il paese di infrastrutture, poi decrescono) sia per cambiamenti tecnologici (i libri cartacei sostituiti da prodotti multimediali digitali): un industriale tradizionale rifiuta ideologicamente il concetto di obsolescenza della sua azienda e di se stesso e finisce per assomigliare a quei combattenti giapponesi che continuavano la guerra nella giungla per anni dopo la resa del proprio paese. Un finanziario è più pronto a disinvestire e qualche volta a saltare nei sub-settori in crescita, ma approvvigionandosi di competenze nuove e adatte alla situazione; non sempre il gioco riesce, come testimoniano le disavventure dei grandi editori o distributori americani di libri e video, spiazzati da Amazon, incapaci di reagire pur in un mercato fluido e pieno di manager informati e competenti. Ma il maggior problema odierno è che gli industriali pensano al proprio settore come caratterizzato da una crescita costante, intervallata da periodi di crisi. Questa infatti è stata l’esperienza storica; quando il mercato tira si mette un po’ di fieno in cascina, quando c’è la crisi si stringe la cintura e si investe per esser pronti quando il mercato riprende. E’ invece possibile che un mondo sempre più caratterizzato dalla finanziarizzazione e dalla globalizzazione proceda di bolla in bolla; i consumi finali e gli investimenti industriali variano da anno ad anno molto più che in passato, ed i valori (delle azioni, degli asset, e dei business) variano di un ordine di grandezza superiore. In particolare, delle autentiche fortune sono state costruite scommettendo sul ribasso di interi settori, cosa che un industriale è assolutamente incapace di fare (per esempio i $ 20miliardi guadagnati dal trader Paulson costruendo un meccanismo adatto a guadagnare sull’implosione dei mutui subprime e del mercato immobiliare americano); l’idea di vendere la propria azienda quando i valori sono al massimo, per poi ricomprarla da chi abbia avuto la sfortuna di acquistarla (magari con molto debito) quando i valori crollano è qualcosa che un industriale non sa nemmeno immaginare, privandosi quindi di una notevole opportunità di creazione di valore. Barilla l’ha fatto negli anni ‘70, ma è stata più una casualità che un disegno strategico.
Incontro di mentalità
Si dice che uno possa trovare solo quello che cerca; se un industriale disprezza, e quindi non cerca di capire come opererebbe un finanziario, non saprà mai trovare un nuovo equilibrio o approfittare di una situazione economica diversa da quella che gli è familiare. E’ tempo quindi di superare la storica dicotomia fra industriali e finanziari; la finanza è una componente fondamentale e inscindibile della gestione ed essere attenti ad approfittare di potenziali variazioni di valore è altrettanto meritorio quanto ridurre i costi o aumentare i ricavi. Un buon esempio sono gli industriali attivi nei trasporti navali per i quali i soldi si fanno talvolta esercendo le linee e talaltra vendendo o comprando navi; alcuni dei più bravi dicono che in realtà essi sono nel business della compravendita delle navi, e che il loro utilizzo nelle linee di navigazione è solo un’attività da svolgere senza perderci troppo aspettando il momento giusto per vendere o comprare le navi. Mentalità finanziaria e mentalità industriale non sono antitetiche; nel medio termine, entrambe sono necessarie e nessuna delle due è sufficiente. E’ difficile che gli operatori finanziari possano creare valore ripetutamente senza il contributo di un partner con mentalità industriale. I manager, dal canto loro, dovrebbero saper sviluppare entrambe le mentalità all’interno della squadra di gestione, privilegiando profili più finanziari e/o distaccati dal business per attività di valutazione strategica. Allo stesso modo, gli imprenditori possono trarre vantaggio dall’associarsi con operatori finanziari che hanno competenze e modi di pensare complementari e sono più attenti a percepire i punti di svolta nelle tendenze macroeconomiche e di business e ad approfittarne anche quando sono negativi.
Puntare alla creazione di valore
Un vero imprenditore deve saper cogliere tutte le opportunità che la sua azienda gli offre; investimenti ma anche disinvestimenti; acquisizioni ma anche vendite di business o aziende; passare in maggioranza o in minoranza; internalizzare o esternalizzare lavorazioni o attività; e se il business storico può solo valere di meno in futuro, approfittare della propria credibilità, forza finanziaria, istinto imprenditoriale e forza manageriale per trovare dove poter continuare a creare valore in un settore diverso. Marco Drago della De Agostini è stato capace di passare dagli atlanti geografici, dalle dispense, e dalle rotative (tutti business precedenti) alla televisione, ai giochi e alla finanza. Per un vero imprenditore l’orgoglio di essere uno specialista del proprio mestiere deve lasciare il posto a quello di essere uno specialista della creazione di valore.