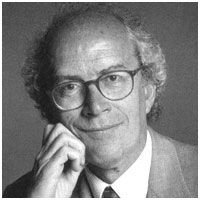
Le tipologie possono esser molteplici; ecco un decalogo
1. Eccesso di autostima e arroganza
Ogni imprenditore, all’inizio della sua parabola ascendente, ha bisogno degli altri: collaboratori valenti ma specializzati, soci finanziari, clienti che “trainano” ecc.. Certamente un imprenditore ha dei meriti, ma mentre all’inizio è molto consapevole dei propri punti di debolezza e tratta come un partner prezioso chi lo aiuta, con l’andar del tempo, e soprattutto se il successo è notevole, l’imprenditore incomincia a pensare che i propri meriti siano notevolmente più importanti dei contributi degli altri; i collaboratori o i partner preziosi sono progressivamente trattati alla guisa di mercenari utili e non come dei partner cui si deve fedeltà e rispetto. Poco alla volta l’imprenditore si circonda di cortigiani, che lo incensano e non lo contraddicono mai, privandosi degli apporti dei “diversi” che una volta cercava.
2. La lusinga della famiglia
Fare l’imprenditore è un mestiere come un altro; talvolta è un mestiere “obbligato” per chi ha poche alternative d’impiego ben remunerato. L’azienda inizialmente è uno strumento per pagarsi uno stipendio, poi, con lo sviluppo, diventa un modo per costituire o accrescere un patrimonio. L’imprenditore accetta di buon grado l’intervento di partner finanziari e/o industriali che permettano di aumentare la sfera di azione dell’azienda e di farla crescere in valore. Con l’andar del tempo, particolarmente se l’imprenditore è di successo e incomincia ad attirare l’attenzione di giornalisti o a ricevere riconoscimenti (come per esempio il Cavalierato del lavoro: pericolosissimo, perché di solito la nomina coincide con l’inizio di un ciclo discendente!), l’imprenditore dimentica il contributo dei partner e pensa di essere il solo artefice del successo; in tal senso, l’azienda non è più percepita come un’entità che ha soci e stakeholders (per esempio i dipendenti) ma come una proprietà personale, alla stregua della casa avita, che si vorrebbe passare di padre in figlio per generazioni. Anche se prima l’imprenditore aveva giurato di voler professionalizzare l’azienda con l’inserimento di manager, il richiamo della famiglia diventa progressivamente più forte, e l’imprenditore sogna di passare il timone al figlio, indipendentemente dalle sue qualità (comunque mai valutate criticamente). Tale “richiamo” è sovente esaltato da figli che non hanno “né arte né parte”, e che se non ricevessero dal padre un titolo altisonante (per es. amministratore delegato dell’azienda) sarebbero considerati dagli altri come delle nullità, ancorché ricchi. L’imprenditore cambia: mentre prima cercava di prendere decisioni logiche adesso la sua visione è obnubilata dall’affetto per il figlio al quale affida posizioni di comando; l’incompetenza de figlio farà poi il danno suo, dei soci e degli stakeholders.
3. Il possesso ad ogni costo
Come in un romanzo di Verga, l’imprenditore che invecchia sviluppa talvolta un desiderio insano di possedere tutto quello che ha creato in azienda, dai capannoni alle attività industriali e magari anche portarselo appresso nell’aldilà. Mentre all’inizio dello sviluppo imprenditoriale le risorse finanziarie erano focalizzate sulle attività fondamentali, il successo e la liquidità generata permette progressivamente di investire in attività ancillari e in immobili. In precedenza ogni attivo poteva esser scambiato o venduto se con il ricavato si poteva far crescere l’azienda in valore o consolidarne la posizione; l’abbondanza di risorse può far perdere focalizzazione e, man mano che avanza l’età, per l’imprenditore diventa sempre più difficile avere un orizzonte temporale lungo per continuare a far crescere l’azienda, magari all’estero. L’imprenditore può sviluppare così un malsano attaccamento a tutto quello che già ha; se vuole possedere una casa più bella se la fa costruire vicino alla fabbrica, se un asset è destinato inevitabilmente a valere di meno in futuro l’imprenditore lo tiene ugualmente, se i soci lo implorano di vendere lui invece vuole aumentare le quote di possesso.
4. Voler essere indispensabile
Un bravo imprenditore, come ogni bravo manager, dovrebbe lavorare per rendersi inutile: delegare ad altri i compiti meno importanti, addestrare i collaboratori a prendere decisioni giuste, ricercare e attrarre manager più bravi di lui per cogliere meglio le opportunità di business. Il risultato di questo lavoro dovrebbe essere un’impresa che si sviluppa anche in campo internazionale, che è più “commerciabile” in quanto meno dipendente da una sola persona, e di un’impresa che possa anche cogliere le opportunità di diversificazione. Talvolta però l’imprenditore che è ad un passo dal raggiungere tali obiettivi è preso dall’ansia di diventare “inutile” e si rituffa nell’operatività per sentirsi appagato. I collaboratori che prima avevano la prospettiva di crescere anche professionalmente sono ora ridotti al rango di meri esecutori con il risultato che i più bravi se ne vanno e gli altri sono demotivati.
5. La crescita ad ogni costo
La crescita è molto importante per un’azienda e in particolare per le aziende italiane che hanno normalmente dimensioni minori dei concorrenti esteri. All’inizio dello sviluppo l’imprenditore sa che deve coniugare crescita con profittabilità, pena l’impossibilità di attirare investitori o finanziamenti bancari; man mano che si consolidano la crescita e i successi di business, qualche imprenditore pensa che si possa perseguire prioritariamente la crescita del fatturato e in seguito, con il (presunto) tocco magico che contraddistingue ogni imprenditore di successo, pensa che la profittabilità sarà raggiunta. A nulla servono le preoccupazioni espresse dei soci, più freddi poiché meno coinvolti nell’operatività e talvolta resi saggi da simili errori sperimentati in passato. Il successo rende l’imprenditore cieco rispetto ai rischi; la parola “fatturato” regna sovrana, la parola “utile” viene utilizzata solo nelle previsioni, la parola “cash flow” esce dal vocabolario.
6. Giocare con i numeri
All’inizio di un percorso imprenditoriale le verifiche sono frequenti: le banche sono preoccupate per i propri crediti, i soci sono preoccupati di dover mettere altri soldi in azienda e l’imprenditore è preoccupato di costruirsi una forte credibilità. L’imprenditore sa che deve presentare frequentemente piani e bilanci credibili che saranno poi confrontati con i risultati. Con il successo talvolta si allenta il rigore e l’imprenditore può perfino sviluppare una certa insofferenza nei confronti di chi vuole discutere di numeri, quasi che non si fidasse del suo intuito imprenditoriale o che non considerasse i successi passati come predittivi dei successi futuri. Talvolta un business può incappare in qualche problema e l’imprenditore è tentato di aggiustare i numeri (per esempio con le valutazioni dei magazzini e con l’ottimismo nei valutare i rischi di credito) contando sulla sua abilità di recuperare successivamente; il desiderio di non intaccare la propria immagine d’imprenditore di successo porta talvolta a innescare un meccanismo infernale per cui progressivamente i bilanci contengono dosi crescenti di valutazioni errate o addirittura veri e propri falsi.
7. I “giri” del private equity
Alcuni imprenditori hanno scoperto il vantaggio di esser finanziati da un fondo di private equity: i capitali disponibili (equity e debito) sono praticamente illimitati e servono per accelerare la crescita dell’impresa. E’ frequente il caso di un imprenditore che viene accompagnato da un fondo per 3-4 anni, dopodiché c’è la vendita a un altro fondo, con l’imprenditore che reinveste nel veicolo utilizzato per l’operazione (NEWCO) e che contiene una massiccia dose di debito bancario (acquisition financing). Fintanto che c’è crescita (ovviamente nel margine lordo, non nel fatturato) tutto va bene e dopo altri 3-4 anni si passa la mano a un terzo fondo, con la stessa tecnica e con dosi crescenti di acquisition financing; il successo passato rende baldanzosi tutti gli attori e non gli fa percepire l’aumento esponenziale del rischio. Basta un incidente di percorso, un flesso nella crescita, un aumento nei tassi d’interesse e l’azienda che fino al secondo “giro” era un gioiello diventa improvvisamente priva di valore, schiacciata dai debiti. L’imprenditore scopre di aver perduto tutto il patrimonio; dall’orgoglio del proprio successo passa alla depressione e al vittimismo.
8. Quando il gioco diventa “a somma zero”
Un imprenditore è ben contento se la propria azienda cresce in valore; ne beneficia lui come i propri soci. Talvolta però, con il passar del tempo, l’imprenditore dimentica il contributo indispensabile che hanno dato i soci apportando capitali e magari anche qualche consiglio utile e pensa che tutto il merito del successo dipenda dalla propria abilità; i soci diventano, ai suoi occhi, come dei “parassiti”, e come tali non meritano rispetto. Se poi succede che ci sono dei problemi, o che in virtù dei patti parasociali i soci di minoranza debbano esser protetti in qualche modo, gli interessi si divaricano. In particolare, può succedere che l’azienda incominci a perdere di valore, e l’imprenditore cerchi di mantenere il valore della propria partecipazione a scapito degli altri soci; per esempio può allearsi con un nuovo investitore che riconosce alle sue azioni un valore superiore a quello riconosciuto a quelle degli altri soci. Inoltre i conflitti di interesse che sono sopiti quando c’è crescita (per esempio i compensi o gli affitti pagati dall’azienda all’imprenditore) esplodono quando il trend si inverte; difficile che l’imprenditore rinegozi con se stesso una riduzione dei canoni di affitto. L’imprenditore che una volta era lo specchio dell’onestà, quando è toccato nel portafoglio non ha esitazione a utilizzarla propria posizione di forza indipendentemente dai contratti o patti parasociali sottoscritti.
9. Quando c’è un divorzio in famiglia
Non è infrequente il caso di due soci o anche due membri di una famiglia che fondano un’azienda e la gestiscono sviluppandola; normalmente l’uno si fida dell’altro, ciascuno si specializza in quello che sa fare meglio e tutto funziona a meraviglia. Dopo anni può accadere che gli interessi divergano, che le rispettive proli scalpitino per avere ruoli manageriali, che s’inneschino delle frizioni e che i collaboratori incominciano a parteggiare per l’uno o per l’altro; se poi qualcuno critica l’altro si può innescare un processo di divisione insanabile. Dove prima c’era armonia e collaborazione si sviluppa acredine e antagonismo. Alla fine non rimane che vendere l’azienda e andare ciascuno per la propria strada e nessuno si capacita di come ci si potesse “essere tanto amati” in passato.
10. Da manager a imprenditore
Imprenditori non si nasce, si diventa. Ci sono dei casi di manager che lavorano bene sotto la guida di un consiglio di amministrazione competente e che però ambiscono mettersi in proprio; in altri casi, a seguito della vendita dell’azienda, un consiglio di amministrazione competente viene sostituito da un “padrone” che può essere culturalmente succube del manager. Ecco quindi che c’è un’opportunità per il manager di espandersi verso un ruolo imprenditoriale, cioè di sviluppare strategie e iniziative senza che nessun altro le possa sindacare; talvolta tutto funziona bene, talaltra c’è invece un disastro in arrivo perché il manager non ha avuto tempo per diventare davvero un imprenditore, ha sottovalutato il contributo di esperienza che prima gli davano gli azionisti o che aveva distillato il precedente e vero imprenditore (per esempio quando l’azienda è venduta a un fondo), e ignora l’utilità della dialettica interna. Il dottor Jeckyll competente, avverso al rischio e conscio dei propri limiti cede il passo a Mr. Hyde che si avventura in iniziative difficilissime, spericolato, prono alla circonvenzione di incapace e che si crede onnipotente.
Una casistica allargabile
Queste 10 tipologie di cambiamento non esauriscono l’universo dei casi possibili; cambiare è nella natura umana ma un imprenditore, che in generale pensa di dover rispondere in primis a se stesso, non ha anticorpi; quando il successo gli monta alla testa, poiché non c’è nessuna autorità superiore che lo controlla (come invece capita per i manager) possono aumentare esponenzialmente la propensione al rischio, il disprezzo per i soci e partner storici, la disinvoltura nel prendere decisioni o truccare i numeri e la tendenza a ignorare gli impegni presi con i propri soci. Questo problema è particolarmente grave per i fondi di private equity che investono in azienda guidate da imprenditori i quali all’inizio si presentano e si comportano come perfetti soci e manager, rispettosi dei ruoli e dei diritti dei propri finanziatori, ma che possono evolvere in modi completamente diversi e che, forti della propria indispensabilità, possono ignorare i patti sottoscritti in precedenza. E’ difficile difendersi dell’emergere nel tempo della sindrome Jeckyll/Hide; l’unica regola potrebbe esser quella di mai diventare soci di qualcuno che ha già avuto troppo successo o che è al terzo “giro” con i suoi investitori.








